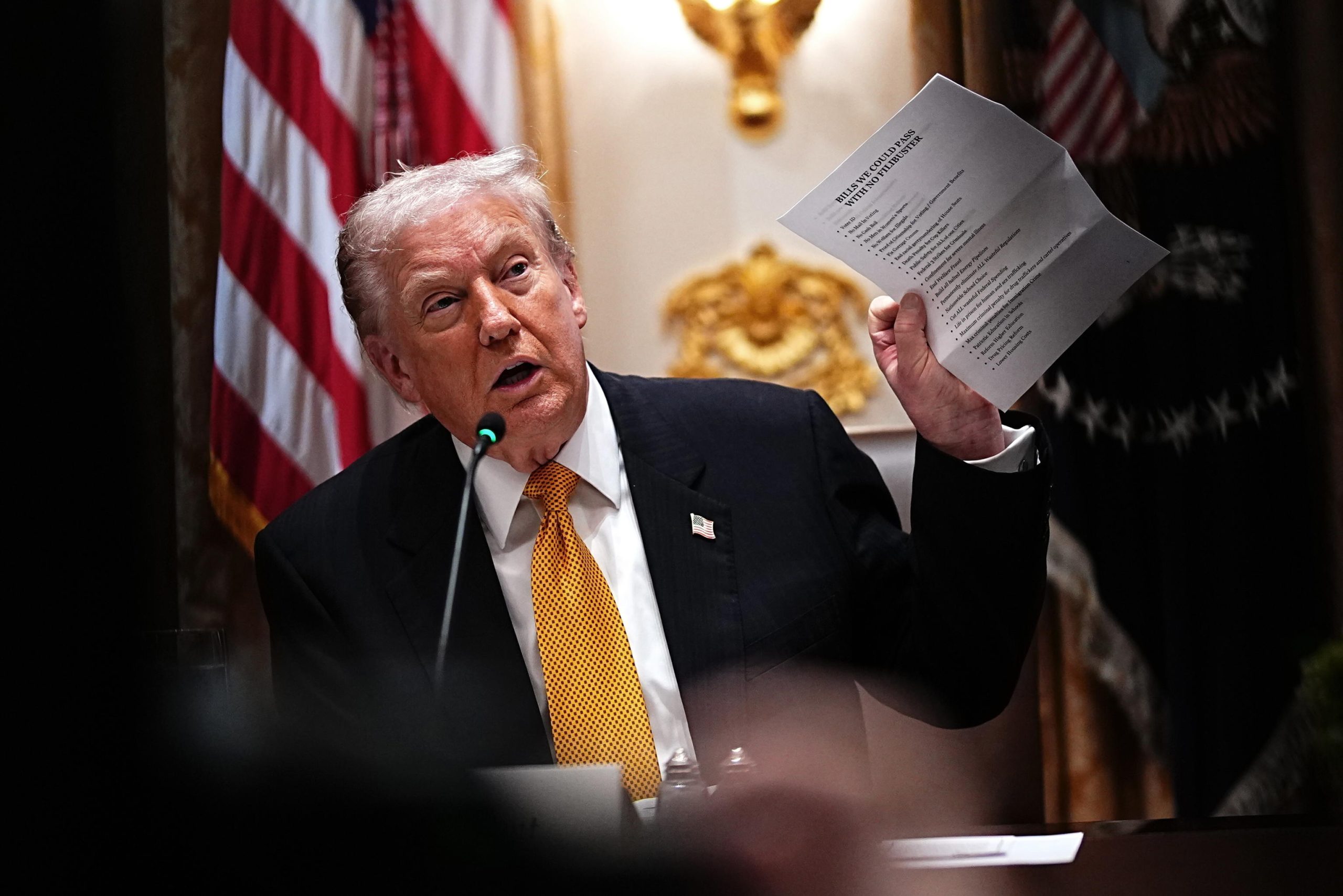
Secondo il politologo brasiliano Emir Sader l’imperialismo del XXI secolo è più complesso di quello del passato e presenta una sua dimensione specifica, quella del capitalismo della speculazione finanziaria. Continua, però, a mantenere la sua vecchia identità, fondata sullo sfruttamento e sulla dominazione a danno di altri Paesi. È moderno ma si fonda sempre su minacce, aggressioni militari e guerre, e non sulle tecnologie più avanzate (oggi in mano alla Cina). Secondo Sader questo imperialismo sta accompagnando il lento e inesorabile declino della potenza statunitense e potrebbe esaurirsi in pochi decenni. Se così fosse, l’agonia di questa modalità di relazione tra Stati, che consiste pur sempre nel controllare l’effettiva sovranità politica di un’altra società attraverso la forza o creando legami di dipendenza economica e culturale, non sarà certo pacifica. Fin d’ora, in un pianeta già pieno di guerre, la politica neoimperialista di Donald Trump sta generando nuova conflittualità e trasformando regioni e Paesi fino a ieri pacifici in focolai bellici. È il caso dell’America Latina, dove da decenni non si verificavano tensioni di questo genere e che oggi si ritrova sull’orlo di un conflitto che potrebbe espandersi oltre i suoi confini, coinvolgendo la Russia. Anche la minaccia di intervento militare in Nigeria, il Paese più popoloso d’Africa, arriva come una doccia fredda per la classe dirigente locale, che aspira a entrare nel gruppo dei Paesi “che contano”. In America Latina è il narcotraffico, in Africa la sicurezza dei cristiani, ma si tratta sempre di alibi per una politica imperiale. Reali o solo minacciati, questi conflitti si moltiplicano e i pretesti non riescono a coprire il reale interesse geopolitico che li scatena, ossia contrastare la Cina in una nuova versione della guerra fredda a pezzi, per parafrasare papa Francesco. Quanto la svolta militarista trumpiana possa diventare concreta, lo si vedrà. In ogni caso, questo “risveglio” degli Stati Uniti, dopo decenni di torpore globalista, fotografa un mondo che in realtà sta sfuggendo dalle loro mani. Un mondo nel quale sono state costruite nuove alleanze e nuove geometrie economiche senza chiedere il permesso a Washington, e men che meno alle decadute potenze imperialiste europee. Ciò che è diventato il collante dei rapporti tra i Paesi, che una volta chiamavamo del Terzo Mondo, è soprattutto l’economia degli scambi, nella quale la Cina è senza dubbio al centro del mondo. Per questo motivo Pechino rifiuta l’uso degli eserciti, rilancia il multilateralismo, si offre per mediare ovunque. È forte del quasi monopolio nella trasformazione di terre rare e litio, del suo primato industriale in settori chiavi come l’elettronica, l’informatica, le tecnologie per la transizione energetica. È conscia del suo peso come compratore, come dimostrato nella trattativa con gli Stati Uniti che includeva l’acquisto di soia da parte della Cina, ma anche della sua inferiorità militare. Intanto, il neoimperialismo statunitense, forse l’ultimo del secolo, fa sì che Washington si scontri con i suoi alleati storici: ne lede gli interessi, mette in dubbio legami consolidati come quello tra i Paesi NATO, si allontana dall’Europa e, quindi, dall’Occidente. È più probabile che questa politica finisca con l’accelerare il declino americano, anziché fermarlo. Tutto nasce da un’illusione, dall’ubriacatura che deriva dal possedere il più grande esercito della storia. Ma nel mondo del XXI secolo non bastano le cannoniere, ci vuole molto di più. Bisogna mettere in campo una politica lungimirante, potenza economica e chiavi di interpretazione aggiornate. Tutte capacità imprescindibili per governare il futuro, ma che a Washington al momento non esistono.


